In caso di mancata osservanza alla presente direttiva la convocata sarà comunque giudicata in contumacia; si ricorda che l’eventuale condanna comminata in contumacia comporta l’automatico raddoppio del massimo delle pene previste per ciascun capo d’imputazione cui sarà riconosciuta colpevole.”
Dovetti rileggere la lettera più volte prima di comprendere appieno in che guaio mi ero cacciata.
Nelle pruriginose chiacchiere di corridoio, si sussurrava di donne ed uomini che avevano ricevuto lettere simili, qualcun’addirittura la conoscevo, ma non si era mai riusciti a sapere, da nessuna di loro, qualcosa di preciso su quel tribunale e sulle pene che comminava: tutte mute come pesci.
Mi maledì per aver accettato quel lavoro e soprattutto le regole assurde che ne governavano la vita anche oltre l’orario di servizio.
Certo, era pagata in modo principesco e alla scadenza del contratto decennale, avrei ricevuto una pensione che mi avrebbe concesso di fare una vita da ricca ereditiera; ma quei dieci anni si stavano rivelando estremamente duri da far passare. La mania di segretezza dei proprietari della Compagnia, imponeva a tutti, dirigenti, impiegati e tecnici, di vivere su quella sperduta isola in mezzo all’oceano; e questo si sarebbe anche potuto capire e sopportare, ma le regole estremamente puritane che governavano la vita di tutti i giorni erano veramente assurde: tutto era programmato, prestabilito, previsto. Divertimenti, feste, sport, passatempi, tutto nei modi e tempi stabiliti dalla proprietà della Compagnia; ma la cosa peggiore era che su tutto imperava una regola ferrea ed irremovibile: il divieto assoluto di contatti intimi con altri impiegati, del proprio o dell’altro sesso, al di fuori del matrimonio.
Io, che, modestamente, a detta di tutti, sono un gran bel pezzo di donna; che nella vita mi ero sempre tolta tutti gli sfizi e le soddisfazioni che un sano corpo pretende, a prezzo di enormi sforzi e sacrifici, ero riuscita a condurre un’irreprensibile vita monastica fino a quel giorno in cui, rimasta a casa per una lieve indisposizione, il mio segretario venne a farmi firmare alcuni documenti urgentissimi. In un pomeriggio pareggiai i conti con quattro anni, tre mesi e dieci giorni di completa astinenza sessuale.
Venerdì 12, alle ore 17,40, ero seduta, da sola, in una piccola stanza inondata di luce artificiale. La parete che avevo di fronte era formata, quasi interamente, da un gigantesco specchio che, presunsi, fosse del tipo che permetteva, a chi era dall’altra parte, di vedere senza essere visto.
Un infermiere mi aveva applicato degli elettrodi autoadesivi sulle tempie, sui polsi, sul collo, collegandomi ad una specie di avanzatissima macchina della verità.
Una voce, proveniente da un altoparlante, mi stava facendo un discorso che, sull’inizio, stentai a capire, tanto ero impaurita e frastornata da tutta quella messa in scena. Riuscì a comprenderne soltanto il senso generale: non so come, ma avevano saputo del mio pomeriggio di follie sessuali. Ero lì per essere giudicata per ogni cosa che era stata fatta. A quel punto mi sforzai per concentrarmi e capire esattamente quello che la voce meccanica stava dicendo.
- … dovrà rispondere con la massima sincerità a tutte le domande che le saranno rivolte, anche se le sembreranno estremamente personali ed imbarazzanti; non è colpa nostra se ha voluto violare le regole che aveva volontariamente accettato. Se tenterà di ingannarci con risposte non veritiere, la macchina lo rileverà immediatamente, e questo non ci indurrà, certamente, ad essere benevoli e comprensivi nel giudizio. Le ricordiamo che lei è libera di sottrarsi a questo procedimento presentando seduta stante le sue dimissioni, nel qual caso, come previsto dall’art. 35 commi 6 e 7 del contratto, lei perderà ogni diritto pensionistico ed in più dovrà pagare una penale pari ai due terzi degli stipendi e gratifiche fin qui percepite. Le è tutto chiaro? -
Sperai che tutto quello che mi stava accadendo non fosse altro che un terribile incubo, e che da lì a poco sarebbe squillata la sveglia per dirmi che era ora di alzarsi.
- Cominciamo con qualche domanda molto semplice, per metterla a suo agio: è vero che il pomeriggio di lunedì 8 ultimo scorso, lei ha infranto la regola del divieto di fare sesso se non sposati andando a letto con il suo segretario? -
Mi sentì avvampare dalla vergogna: messo in quei termini tutto diventava volgare e squallido.
- La preghiamo di rispondere immediatamente senza tentennamenti; grazie. -
Alla mia risposta positiva seguirono altre domande sempre più intime e veramente imbarazzanti: chi aveva cominciato?; quale indumento mi ero tolto per primo?; glielo avevo preso in mano?; e in bocca?; se mi ero fatta leccare; se avevo provato piacere; se me lo aveva messo dietro; lo avevo chiesto io di mettermelo dietro o aveva insistito lui? avevo provato dolore?. Questo interrogatorio andò avanti per almeno un’ora. Cercai di rispondere a tutto nel modo più sincero e, per me, meno imbarazzante possibile.
- Con le domande abbiamo concluso. A parte qualche indecisione, ci risulta che lei abbia risposto in modo sufficientemente veritiero: questo depone a suo favore e ne terremo conto. Tra poco le comunicheremo le nostre decisioni. -
L’attesa durò più a lungo di quanto mi aspettassi. Non sapevo cosa pensare, non riuscivo ad immaginare quale pena mi sarebbe stata comminata. Secondo qualche voce incontrollabile che era girata negli uffici, si parlava addirittura di punizioni corporali; ma in fondo, nessuno ci credeva veramente: mica eravamo nel Medio Evo.
- Signora Clara, – la voce dell’altoparlante mi colse di sorpresa facendomi sobbalzare – questa Commissione ha esaminato a fondo il suo caso giungendo ad una decisione unanime. La preghiamo di alzarsi per ascoltare il verdetto. -
Con un groppo in gola che m’impediva di respirare normalmente, mi alzai per ascoltare cosa avessero deciso.
- Signora Clara, questa commissione, visti i documenti agli atti ed ascoltata la sua confessione spontanea, la dichiara colpevole di aver compiuto atti osceni con un impiegato a lei direttamente subalterno con l’aggravante di ripetuta fellazio e sodomia consenziente. In considerazione della sincerità e del modo esauriente con cui ha risposto alle domande, noi la condanniamo a quaranta ore complessive di terapia elettrica. Esecutore della condanna sarà il Primo Dirigente Medico della Compagnia. Le sarà notificato, per tempo, dove e quando dovrà iniziare a scontare la sua punizione. Così abbiamo deciso. -
Un forte colpo, che presunsi fosse quello di un martelletto battuto sul tavolo, fu l’ultima cosa che sentì da parte dei membri della Commissione. Crollai di schianto sulla sedia: Terapia Elettrica? E che diavolo era?
Non avevo la più pallida idea di cosa fosse; e ne dovevo fare quaranta ore.
Nei giorni seguenti cercai, con molta circospezione, di sapere qualcosa su questa maledetta Terapia Elettrica. Dopo lungo cercare, qualcuno mi suggerì di chiedere alla ragazza responsabile della spedizione potale: “lei, forse, ne sa qualcosa”.
Andai subito a cercarla.
-
Mi chiamo Clara M., vorrei farle qualche domanda. -
-
Prego, – rispose molto gentilmente – mi dica … -
-
Ecco, la cosa è un poco imbarazzante … la Compagnia mi ha imposto di fare quaranta ore di terapia elettrica, e, non so se lei può aiutarmi, ma vorrei saperne qualcosa di più, visto che non ne so praticamente niente. -
L’atteggiamento della ragazza cambiò di colpo; abbassò gli occhi e la sua fronte s’imperlò di sudore..
-
Spiacente, ma di questo non ne posso assolutamente parlare. – Era letteralmente terrorizzata.
-
Ma io voglio soltanto saperne qualcosa -
-
Signora, le ripeto che non ho il permesso di discutere sull’argomento né con lei né con chiunque altro. Ed ora, se mi vuole scusare, ho molto da fare. -
E con questo si chiusero anche le mie ricerche.
Quella stessa mattina, avevo ricevuto la lettera di convocazione per il giorno 19, anche quello era un venerdì, sempre alle ore 17,30. Appena terminato l’orario di lavoro, quindi, dovevo presentarmi presso lo studio del Dirigente Medico, al quinto piano della palazzina dirigenziale.
Venerdì 19, il tempo sembrò accorciarsi; le 17,00 arrivarono fin troppo presto. Con più ansia che paura, mi avviai verso la palazzina dirigenziale. Presi l’ascensore e spinsi, con un certo batticuore, il pulsante del quinto ed ultimo piano: era la prima volta, in tanti anni, che salivo a quel piano.
Quando le porte dell’ascensore si aprirono mi trovai di fronte ad una scrivania occupata da un’infermiera molto grossa. Non grassa e flaccida; ma un donnone grande e grosso che sembrava un’orsa in uniforme.
Mi sentì morire: quella donna stava leggendo un incartamento che poteva essere la mia confessione; tutto quello che avevo fatto e mi ero fatta fare dal mio segretario. Sperai con tutte le mie forze che così. Ogni tanto alzava gli occhi dai fogli e mi guardava con un ghigno sulle labbra.
- Per favore, mi segua. – mi ordinò, alzandosi, appena ebbe richiuso l’incartamento.
Aprì una porta e mi fece entrare in una piccola stanza. Su un gancio alla parete era appeso un camice verde da ospedale.
- Si spogli completamente ed indossi quel camice. L’apertura è alle spalle. – aggiunse indicandomi con un gesto che dovevo indossarlo dal davanti.
Per mia fortuna uscì chiudendosi la porta alle spalle: sarei morta dall’imbarazzo se avessi dovuto fare tutto in sua presenza. Mi spogliai completamente e riposi i miei indumenti nella borsa che trovai attaccata ad un altro gancio. Il camice che dovetti indossare era del tipo ospedaliero, con l’apertura alle spalle ed un unico laccio sul collo; oltre tutto era estremamente corto, mi copriva appena l’attaccatura delle cosce.
Uscì dallo stanzino cercando di stringere, sul didietro, i lembi del camice: non mi andava affatto di girare con le natiche al vento.
Se solo avessi immaginato quello che stava per capitarmi… .
L’orchessa, nuovamente seduta alla sua scrivania, mi fissò con uno sguardo che non lasciava presagire niente di buono.
-
Infermiera – le chiesi con una notevole trepidazione – mi può dire cosa sta per accadermi? -
-
Posso dirle soltanto che devo prepararla per la sua punizione. Di più proprio non posso. Ma non stia lì a preoccuparsi; saprà anche troppo presto quello che l’aspetta. Ed ora mi segua nello studio del medico. Prego. -
Si alzò e s’indirizzò verso un’altra porta.
La stanza in cui mi fece entrare era molto grande; c’era un lettino da visita, una poltrona ginecologica con tanto di staffe poggia piedi, armadi a vetri ripieni di strumenti vari. Insomma, tutto quello che normalmente si trova in uno studio medico ben attrezzato.
Con un blocco in mano su cui segnava tutti i risultati, l’infermiera mi pesò, prese la mia altezza e tutte le altre misure del corpo facendomi contemporaneamente molte altre domande riguardanti il mio ciclo mestruale e cose del genere. Appena finito, mi diede una tazza e mi ordinò di andare dietro il paravento: le occorreva un campione della mia urina.
Stentai a farmene uscire le poche gocce necessarie: incominciavo ad essere veramente preoccupata.
Appena uscita dal paravento, m’indicò il lettino da visita: compresi che mi ci dovevo stendere sopra.
Mi misurò la pressione del sangue e prese nota delle mie pulsazioni, dopo di che, rovistando in uno degli armadi, mi ordinò di voltarmi pancia sotto.
La guardai allibita quando la vidi tornare verso di me con un lungo termometro ed un barattolo di vaselina.
Dio, questa è la cosa più imbarazzante che potesse capitarmi.
Infilò l’indice della destra nel barattolo e lo tolse carico di un grumo di vaselina.
- Ora faccia un bel respiro profondo. -
Non feci in tempo ad aprire la bocca che mi ritrovai il suo dito piantato tra le natiche. E ci prese anche gusto, quella perfida sadica; aveva un dito grosso come una trave e me lo spingeva e rigirava dentro come se stesse lavando il collo di una bottiglia. Anche se non volevo dargliela vinta, non potei fare a meno di lamentarmi.
- Oh, e che sarà mai … so che ci si è fatta infilare ben altro qui dentro. In fondo è soltanto il mio dito. -
La maledetta sapeva. Sapeva che mi ero fatta inculare dal mio segretario: era proprio la mia confessione che stava leggendo mentre aspettava che io arrivassi. Sentì il mio viso diventare di fuoco mentre mi infilava il termometro fino in fondo.
Mi tenne le natiche ben strette per almeno cinque minuti, poi tolse il termometro, lo pulì e lesse la temperatura. La garza con cui aveva pulito lo strumento era macchiata di marrone: diventai ancora più rossa per l’imbarazzo.
- Così non và proprio – disse indicando la garza sporca – dobbiamo fare in modo che lei sia perfettamente pulita: non si muova. -
Andò verso un altro armadio pieno di medicinali e tornò con una piccola scatola in mano. Ne trasse tre supposte e, allargandomi di nuovo le natiche, me le infilò fino in fondo, una dietro l’altra, spingendo e torcendo il dito come aveva fatto prima. Non contenta delle umiliazioni che mi stava infliggendo, mi assestò uno sculaccione per nulla amichevole e mi ammonì di tenerle fino a che non ne potessi più prima di andare a svuotarmi, se non volevo che il seguito fosse ancora peggiore.
Le supposte iniziarono ben presto il loro perfido lavoro: il mio pancino era sconvolto da movimenti interni che mi facevano sudare per lo sforzo di non farmela addosso; ma non volevo chiedere troppo presto, al cerbero, il permesso di andare in bagno; credevo sul serio alla sua minaccia.
Mentre io mi torcevo sul lettino, la sentii armeggiare negli armadi: sicuramente stava preparandomi qualche altra brutta sorpresa.
- Credo che le piccole amiche abbiano fatto il loro dovere: può anche andare in bagno, ma faccia in fretta. Non abbiamo ancora tanto tempo da perdere. -
Non me lo feci ripetere due volte. Schizzai dal lettino con la velocità di una centometrista e mi precipitai sulla tazza del cesso sperando di fare in tempo per non lasciare, dietro di me, una scia marrone.
Feci prima che potei, ma lei sicuramente lei giudicò che ci avessi messo troppo tempo. Mi lavai ed asciugai in fretta e tornai nella sala del medico.
Lei era in piedi, vicina al lettino, con un’espressione che non lasciava presagire nulla di buono. Accanto a sé aveva preparato un’asta porta flebo con appesa una sacca di plastica ricolma di liquido lattiginoso, dalla quale pendeva in tubo terminante con un piccolo rubinetto.
Come un automa mi avvicinai al lettino: oltre le supposte, anche un clistere; e sì che era una cosa che odiavo con tutta me stessa.
Seguendo le ingiunzioni dell’orchessa mi stesi sul fianco sinistro piegando il ginocchio destro verso il petto. Mentre mi tormentava di nuovo il buchetto con il suo dito, con la scusa di lubrificarmelo, pensai, tra me e me, che doveva essere sicuramente questa la punizione decretata nella condanna: cosa poteva capitarmi di peggio?
Con un lamento accolsi nel mio retto la grossa cannula del clistere.
- Respiri a fondo e si massaggi la pancia nel caso dovessero venirle i crampi: deve essere perfettamente pulita; quindi, questa sacca dovrà sorbirsela tutta. -
Mentre sentivo l’acqua molto calda riempire tutte le mie viscere, mi chiesi per quale motivo dovevo essere “perfettamente pulita”; poi mi ricordai della “terapia elettrica” ed allora cominciai ad avere il sospetto che il clistere poteva essere soltanto una preparazione e non la punizione.
Intanto l’infermiera aveva posto un grosso secchio a fianco del lettino.
- Dopo che le avrò tolto la cannula, aspetti qualche minuto poi si svuoti nel secchio: devo controllare che l’acqua sia pulita, senza tracce di feci. -
Mi sentivo la pancia gonfiarsi come una mongolfiera; intanto la mia aguzzina preparò un’altra sacca grossa quasi il doppio della precedente. Dal ghigno con il quale guardava le mie smorfie di dolore ad ogni crampo, mi resi conto che se anche avessi fatto acqua limpida come quella di sorgente, tutto il liquido di quella sacca sarebbe comunque finito nella mia pancia.
Se io dovevo essere perfettamente pulita dovetti convenire, mio malgrado, che il secondo clistere era necessario. Come mi fece perfidamente osservare l’infermiera, nell’acqua c’erano ancora tracce di cacca.
Non so come feci a ricevere tutta la seconda sacca: mi sentivo la pancia piena da scoppiare; e prima di darmi il permesso di svuotarmi, la perfida me lo fece anche trattenere per alcuni minuti.
Per mia fortuna, l’acqua mi uscì abbastanza chiara e non dovetti sorbirmi un terzo clistere.
-
Ed ora svelta, sulla poltrona, con le gambe sulle staffe: la devo rasare completamente. -
-
Mi deve rasare? – chiesi con angoscia – perché mi deve rasare? -
-
Perché è scritto sulla sentenza; ecco perché. “la condannata dovrà essere completamente rasata nella zona pelvica e nella zona anale prima di subire la punizione”. Soddisfatta? -
Oh dio mio, ma cosa volevano farmi?
Avevo le lacrime agli occhi mentre mi legava le gambe spalancate alle staffe della poltrona ginecologica.
- Non preoccuparti che ti ricresceranno più forti e ricci di prima – commentò mentre mi passava il rasoio di sicurezza attorno all’ano, dopo avermi ben insaponata con un morbido pennello da barba – per ora devi presentarti liscia e pulita come una bambina. -
Proprio mentre stava completando la rasatura, la porta si aprì per lasciare entrare un uomo alto e brizzolato che indossava un camice da medico. Mi sentì morire dalla vergogna: neanche il mio ginecologo mi aveva mai vista conciata in quel modo.
-
Buon giorno, sono il Medico Capo. Le farò uno screening completo e la preparerò per ricevere al meglio la sua punizione. È pronta, infermiera? -
-
Ancora in istante. Finisco di asciugarla ed è tutta per lei. -
Calzando lo stetoscopio sulle orecchie, il medico mi si avvicinò senza dire una parola; attese che l’infermiera mi slacciasse il camice dietro la schiena e me lo togliesse, poi cominciò ad auscultarmi cuore e polmoni. Prese degli appunti poi mi tastò le mammelle; palpeggiandole a piene mani, mi strizzò i capezzoli facendomi un male cane. Il tutto senza dire una sola parola.
Prese altri appunti poi finalmente si rivolse a me chiedendomi se avessi mai avuto problemi di cuore o di circolazione. Annuì soddisfatto alla mia risposta negativa ed ordinò all’infermiera di accostare lo sgabello tra le mie gambe: doveva procedere all’esame ginecologico.
Ormai stavo perdendo ogni senso di dignità: il mio corpo veniva usato e trattato come un sopramobile in vendita: osservato, palpato e girato in ogni sua parte.
Il dottore si chinò tra le mie cosce spalancate dopo aver indossato un paio di guanti chirurgici. Odiavo sentirmi invadere da quelle dita impersonali avvolte nel lattice. Chiusi gli occhi appena vidi l’infermiera avvicinare un carrello d’acciaio ricolmo di strumenti.
Mi sentì dividere le grandi labbra ed un paio di dita entrare senza riguardo, spingendo a fondo, nella mia vagina. Con l’altra mano il medico premette su vari punti del mio addome.
Dal gelo che avvertì tra le mie cosce, capì che mi aveva infilato dentro uno specolo d’acciaio; ed era anche di dimensioni notevoli: era molto più grande di quello che usava il mio ginecologo. Spalancai gli occhi per il dolore quando lo allargò, improvvisamente, al massimo: sembrava che mi stesse squarciando.
Vidi appena il fascio di luce della lampada tascabile che si indirizzava verso il mio pube.
- Uhm, – lo sentì borbottare – questa cervice è molto stretta. Dovremo allargarla. Infermiera, mi passi un divaricatore da 0,4, credo che sarà sufficiente. -
Mi sentì agghiacciare: ma cosa volevano farmi?
Come in risposta alla mia tacita domanda il medico si degnò di dirmi cosa stava per farmi.
- Vede signora Clara, il suo utero ha il foro sulla cervice molto stretto. Siccome dopo dovrò inserirle una piccola sonda, adesso glielo dilaterò un poco, così al momento opportuno, non ci saranno problemi. Sentirà in piccolo dolore, ma lei non incominci a preoccuparsi. Passerà in fretta. -
Non “dovevo” cominciare a preoccuparmi: ero “già” preoccupata, e da un pezzo.
Sentì come una stilettata nella mia pancia; mi lamentai ma il medico disse che era già tutto fatto. Porse il dilatatore all’infermiera e chiudendolo, sfilò lo specolo.
Pensai che la vagina non mi si sarebbe mai più richiusa: sentivo l’aria circolare dentro di me come in una stanza con la finestra aperta.
Per un attimo ebbi la sensazione che la visita fosse finita, ma mi sbagliavo; il medico stava soltanto immergendo di nuovo le dita guantate nel barattolo della vaselina. Immaginai dove le avrebbe infilate ed infatti, un attimo dopo, sentì due dita invadere nuovamente il mio già martoriato posteriore. Ormai non riuscivo più neanche a provare vergogna; mi sentivo come se il mio corpo non fosse più il mio. Ad un’altra donna stavano invadendo ed allargando, senza ritegno, tutti gli orifizi; non a me.
- Mi sembra che stia tutto a posto; non sento né ragadi né emorroidi. Penso che possiamo procedere. Il soggetto è in buona salute e può tranquillamente sopportare la punizione comminata. -
Oh, finalmente era finita questa maledetta visita. Assurdamente, non vedevo l’ora che cominciasse la punizione: sicuramente non potevano farmi niente di peggio.
- Mi scusi, ma non c’è pericolo che la donna se la faccia sotto all’inizio del trattamento? -
Maledetta infermiera: ma perché non si faceva gli affari suoi? Mi aveva svuotato con le supposte ed i clisteri; cos’altro potevo “farmi sotto” ancora?
- Sì, ha ragione; è già successo una volta. Mi prepari un catetere ureterale. -
Sentì il sangue che mi si faceva acqua. Questi erano pazzi. Avevo capito il senso della richiesta del medico e sapevo cosa stava per farmi: no! Questo non glielo avrei lasciato fare.
Come se mi avesse letto nel pensiero l’infermiera mi applicò un’altra cinghia sulle cosce. Adesso avevo le gambe assolutamente immobilizzate.
Il medico si chinò nuovamente tra le mie gambe allargandomi le grandi labbra, poi manovrando un poco, sentì che metteva a nudo il mio buco per la pipì. Con un tampone, strofinò e disinfettò la parte, facendomi provare un notevole bruciore che aumentò, in modo irresistibile, quando cominciò ad infilarmi dentro il catetere che gli aveva porto l’orchessa.
Lo sentì scorrere e bruciare dentro di me man mano che il medico spingeva. Ad un tratto mi ordinò di guardare in basso: dall’estremità libera del tubicino, sgorgava un liquido giallognolo. Ci misi un po’ a capire che era la mia urina che stava uscendo: mi stavano facendo pisciare sotto.
Erano riusciti anche a farmi provare nuovamente vergogna. Ancora di più sperai che la punizione cominciasse presto: non poteva assolutamente essere peggiore di quello che avevo dovuto sopportare durante tutta la visita.
Finalmente sembrò che tutto fosse veramente finito. L’infermiera usci dalla stanza mentre il medico mi aiutò a scendere dalla poltrona ginecologica lasciandomi in piedi, nuda come un verme.
Con un moto d’istintivo pudore, le mie mani scesero a coprire l’inguine. Trovai quasi comica la sensazione tattile del sentire la pelle del mio pube priva di peli.
Avevo appena indossato nuovamente il camice quando la strega tornò accompagnata da due colossi vestiti da infermieri.
Ecco; il momento della punizione era arrivato.
- Per cortesia, signora, apra la bocca; la spalanchi. – ordinò uno dei due tenendomi saldamente la testa da dietro le spalle.
Ero quasi tentata di rifiutarmi quando l’altro mi assestò un violento sculaccione convincendomi a non opporre resistenza. Appena ebbi spalancata la bocca me la riempì con una grossa palla di gomma che m’impediva di respirare liberamente.
- Respiri con il naso. La palla di gomma serve a salvaguardare i suoi denti. – mi spiegò mentre legava dietro la mia nuca i lacci che fuoriuscivano dalla palla.
Ora, con la bocca così piena, potevo soltanto mugolare.
Appena terminato, mi si accostarono, uno per lato e, tenendomi per le spalle, mi fecero uscire dallo studio del medico capo.
Il tragitto fu un tormento: il camice mi lasciava completamente scoperto il sedere e sentivo lo sguardo dei due uomini soffermarsi sulle mie belle natiche ondeggianti mentre camminavo.
La stanza nella quale mi accompagnarono era molto grande; conteneva una decina di comode poltrone disposte a semicerchio attorno ad un’enorme poltrona ginecologica molto più complessa ed attrezzata di quella della stanza del medico.
Quello che mi colpì, in particolare, di quella poltrona, fu il sedile; era fatto a forma di U, con una striscia vuota al centro.
I due infermieri mi fecero sedere sulla poltrona e mi posizionarono le gambe su particolari staffe, del tipo in grado di sorreggere tutto l’arto, dalle cosce ai piedi, poi, con delle cinghie, mi legarono alle staffe in modo che, le mie gambe, non potessero più compiere il minimo movimento.
Feci appena in tempo ad abituarmi a quella scomoda posizione che, con altre cinghie, mi legarono il busto allo schienale della poltrona, facendolo poi reclinare fino a farmi distendere quasi completamente; infissero dei lunghi pioli ai lati dello schienale e mi ci legarono a braccia distese, proprio come se mi avessero messa in croce. L’infermiera, che ci aveva raggiunti da poco, mi bloccava intanto la testa con una specie di cuffia infissa al bordo superiore della poltrona.
A quel punto ero veramente terrorizzata: il mio corpo non poteva fare il minimo movimento; ero in loro completa balia.
Con la coda dell’occhio vidi l’orchessa impugnare un paio di forbici ed avvicinarsi in modo minaccioso. Tentai di gridare, ma la palla che avevo in bocca m’impedì di emettere qualsiasi suono.
Fortunatamente le forbici non erano per me, per staccarmi qualche pezzo di corpo, come avevo paventato, ma semplicemente per tagliare il camice e denudarmi di nuovo, completamente.
I due infermieri, nel frattempo, avevano afferrato le staffe che mi imprigionavano le gambe, ed avevano cominciato a divaricarle fino al punto che ebbi l’impressione di essere squartata in due: avevo le cosce talmente allargate da sembrare una ballerina mentre fa la spaccata.
Soltanto allora mi accorsi che in alto, sul soffitto, c’era uno specchio che mi consentiva di vedere perfettamente tutto il mio corpo e, purtroppo, tutto quello che mi avrebbero fatto.
L’infermiera mi applicò il bracciale dello sfigmomanometro e stava proprio completando la misurazione della pressione quando rientrò il medico capo. Non era solo: era accompagnato da un gruppo, in maggioranza uomini, tutti con una maschera sul volto. I nuovi entrati si accomodarono, in silenzio, sulle poltrone disposte a semicerchio attorno a me.
Sentivo i loro sguardi violare il mio corpo; tutte le mie intimità spalancate ed in piena vista. In quel momento avrei preferito mille volte essere morta che stare lì, in quelle condizioni, di fronte a quei porci che si pascevano della mia vergogna.
Sentì le lacrime scorrere abbondanti sulle mie guance e cominciai a maledirmi per quelle poche ore di godimento trascorse con il mio segretario.
I due infermieri avvicinarono alla mia poltrona due carrelli con due diverse strumentazioni.
Uno di quegli apparecchi, lo conoscevo, era un elettrocardiografo; l’altro, pieno di manopole e di lampade spia mi era del tutto sconosciuto, ma non m’ispirava niente di buono.
Il primo apparecchio a cui venni collegata fu l’elettrocardiografo. Mi applicarono gli elettrodi adesivi ai polsi; alle caviglie; ai lati della fronte e sul torace.
Bip … Bip … Bip … , la macchina era accesa e segnalava la frequenza dei miei battiti cardiaci.
- Prova dolore. – annunciò ad alta voce il medico capo che stava tarando l’apparecchio.
L’infermiere che mi aveva applicato gli elettrodi al torace afferrò le mie belle tette con tutte e due le mani e le strizzò fino a farmi mugugnare dal dolore.
I Bip accelerarono di colpo.
- Stop. – ordinò ancora il medico.
L’infermiere aprì le mani ed i battiti cominciarono lentamente a rallentare.
- Ancora. – chiese nuovamente il medico dopo aver girato alcune manopole della macchina.
Questa volta l’infermiere si accanì sui miei capezzoli: li prese tra indice e pollice torcendoli e strizzandoli come si fa con le palline di mollica di pane.
- Perfetto. Tutto a posto. Possiamo anche incominciare la preparazione. -
Le parole del medico mi fecero capire che il momento di scontare la mia punizione si stava avvicinando. Dopo tutto quello che già avevo passato non sapevo se esserne felice o meno. Cosa poteva capitarmi di peggio? Nulla! Almeno questo era quello che credevo.
Dallo specchio vidi l’infermiera avvicinarsi con una bacinella e un paio di pinze a molla in mano. Usando le pinze prelevò dalla bacinella un batuffolo d’ovatta impregnato di uno schifoso liquido marrone e cominciò a passarmelo, sfregando con vigore, sui capezzoli prima, poi su tutta la mammella sgocciolando su tutto il torace. Il liquido era appiccicoso e ghiacciato. Mi lamentai, per quanto potevo, ma lei non se ne curò; poi si trasferì in mezzo alle mie cosce, e prelevato un nuovo batuffolo, me lo strofinò su tutta la vagina spalancata. Sentì il liquido scorrere in giù fino a bagnare il mio ano. Con un terzo batuffolo strofinò, facendomi veramente male, l’interno della vagina: il freddo era terribile, tanto che sentì, subito, le mia pelle reagire facendosi a buccia d’arancia. Fu poi la volta dell’ano. Anche lui ricevette lo stesso trattamento: prima fuori, poi dentro; e la perfida si divertì a sfregare ben bene nel mio buchetto, entrando ed uscendo più volte con batuffoli sempre nuovi e, mi sembrava, sempre più impregnati di quel liquido appiccicoso e ghiacciato.
Dai Bip … Bip… emessi dalla macchina capì che le mie pulsazioni stavano accelerando nuovamente. Anche il medico se ne accorse, ma con mia grande sorpresa, invece di fare qualcosa per tranquillizzarmi, anche lui si mise a strizzarmi le tette facendomi un male boia.
Stranamente, dopo aver accelerato, i miei battiti tornarono praticamente nomali. Ormai, mi venne di pensare, non provo più niente: pudore, vergogna, dolore. Mi stanno abituando a tutto. Qui ci sono una decina di persone che stanno guardando la mia fica rasata, il mio culetto senza peluria, una pinza con un batuffolo di ovatta che entra ed esce dal mio culo e non me ne frega più niente. Mi hanno ridotta una puttana senza pudore.
L’infermiera mi riscosse dalle mie auto commiserazioni prelevando un fascio di fili elettrici, dal ripiano sottostante la macchina che non conoscevo, e li posò sul mio stomaco man mano che li collegava agli spinotti della macchina. Ad alcuni capi liberi collegò delle pinze a molla del tipo reggi fogli, ma con i bordi irti di dentini.
Temetti di indovinare dove volevano mettere quelle terribili pinzette e sentì un brivido di paura scorrere lungo tutta la mia schiena.
- Signora Clara, – la stessa voce che riconobbi subito essere quella che mi aveva parlato durante il processo, era in piedi davanti a me, proprio al centro tra gli spettatori. – contro di lei è stata emessa una condanna a quaranta ore di elettro terapia. Lei oggi subirà dieci ore della terapia comminata. E così sarà per ogni Venerdì delle prossime tre settimane finché non avrà scontato completamente la sua condanna. Soltanto allora lei ritornerà nel pieno possesso di tutti i suoi diritti. Le persone, che sono qui davanti a lei, sono i giudici che hanno emesso la condanna e che testimonieranno che lei ha scontato completamente la pena. Si cominci. -
Un’ondata di terrore mi travolse all’improvviso: non sapevo cosa mi avrebbero fatto da quel momento in poi, ma sapevo ben che avrei dovuto subire per altre tre volte lo stesso calvario subito fino ad allora. Mi misi a piangere come una bambina mentre il medico si piazzava al centro delle mie cosce spalancate.
Non volevo sapere, ma gli occhi mi rimasero spalancati ad osservare il dottore che prendeva uno dei fili dalla mia pancia e lo collegava ad un lungo tubicino di metallo terminante con un microscopico rubinetto; me lo posò nuovamente sullo stomaco per prendere un altro cavetto che fu collegato ad un cono, lungo e stretto, con in punta una piccola pallina. Anche questo attrezzo finì insieme all’altro. Il terzo ed ultimo filo libero fu collegato ad una specie di gigantesca oliva allungata che, notai mio malgrado, era forato nel senso della lunghezza. Anche questo terminava con un rubinetto.
Mentre il medico compiva queste operazioni, riapparvero i due infermieri: ognuno portava un’asta porta flebo su rotelle che posizionò ai miei fianchi; ai ganci c’erano appese delle sacche di plastica, piccole e grandi, ma tutte gonfie e che riconobbi immediatamente: le stesse con cui mi avevano fatto i clisteri un secolo prima.
Non ebbi neanche il tempo di commiserarmi.
- Adesso, Clara, ti inserirò questo catetere – disse il medico impugnando il tubicino metallico, – nel canale ureterale, quindi riempirò la tua vescica con liquido sterile e chiuderò il rubinetto. -
Si chinò tra le mie gambe, allargò le mie grandi labbra ed infilò il catetere nel mio canale urinario. Un bruciore insopportabile mi scosse da capo a piedi: tentai di gridare, di fermarlo, ma fu tutto inutile. Lo vidi collegare il tubicino piantato dentro di me a quello pendente dalla sacca più piccola; immediatamente dopo cominciai a sentirmi la vescica piena, sempre più piena come se stessi per farmela sotto: ma non potevo. Il rubinetto che il dottore aveva chiuso mi impediva di fare pipì.
- Questo divaricatore a cono, invece, le sarà inserito nel collo dell’utero. -
In mano aveva anche uno specolo di dimensioni gigantesche. Me lo infilò nella vagina e lo allargò fino a togliermi il fiato.
- La cervice dell’utero è molto ben visibile ed il foro è già stato allargato, – disse rivolto non so a chi – farò in un attimo. -
Un dolore atroce, in basso, nella pancia, mi segnalò che la pallina era entrata nel mio utero, poi sentì, oltre al dolore che aumentava, la spinta dell’attrezzo che sembrava volesse arrivarmi fin nello stomaco: ero già distrutta e le dieci ore erano appena cominciate. Cos’altro volevano farmi ancora?
- Inserirò questa grossa cannula nel suo ano e le riempirò l’intestino con almeno quattro litri di soluzione salina sterile; questo consentirà alla corrente di correre lungo tutto il suo intestino. -
Oh dio, ma cosa volevano farmi? Fulminarmi?
Lo vidi abbassarsi nuovamente. Mi infilò senza tanti riguardi un paio di dita cariche di vaselina nell’ano. Le tolse, le infilò nuovamente nel barattolo di lubrificante e me le spinse di nuovo dentro. Questa volta doveva avermene infilate almeno tre: mi sentì l’ano dilatarsi come non avevo mai provato; poi, con un unico movimento, sfilò le dita e mi piantò quel gelido paletto nell’intestino. Immediatamente dopo aprì il rubinetto e l’acqua cominciò ad inondarmi.
Fu la volta delle pinze. Ne prese una e si chinò nuovamente tra le mie cosce cominciando a masturbarmi il clitoride.
Ero in una situazione folle eppure, incredibilmente, sentì che il mio sesso rispondeva. Sentivo il clitoride gonfiarsi sotto le esperte manipolazioni del dottore. Improvvisamente un dolore atroce, mai provato: i denti delle pinze stavano mordendo spietatamente il mio piccolo bottoncino gonfio.
Ero piena da scoppiare: quattro litri di liquido nella pancia; la vescica gonfia come un pallone; abbassai gli occhi e vidi la mia pancia sformata come se fossi in cinta; il clitoride mi mandava pulsazioni dolorose da impazzire. No. Ero certa di non farcela a resistere per dieci ore.
Quasi non mi accorsi di quando mi applicarono le altre due pinze ai capezzoli. I crampi alla pancia mi stavano facendo impazzire.
- Come avete avuto modo di constatare con i vostri occhi, – disse il medico evidentemente ai membri della giuria – sono stati immessi oltre quattro litri di liquido nella pancia della condannata. Il gonfiore si può notare senza sforzo; in più, abbiamo immesso nella sua vescica 500 cc. di liquido sterile. La vescica dovrà essere svuotata ogni due ore e quindi nuovamente riempita. Gli elettrodi sono stati tutti collegati, quindi siamo pronti per cominciare la punizione. -
Udì gli scatti di alcuni interruttori e subito dopo cominciai ad avvertire uno strano formicolio. Formicolio alle mammelle, formicolio nella vescica, nella vagina, nel mio culo ed in tutta la mia pancia e soprattutto al mio clitoride. Lentamente il formicolio aumentò; mi sentivo stranamente tesa aspettando l’immancabile dolore che ero certa stesse per arrivare. Con sgomento, invece, mi accorsi improvvisamente di avere gli occhi spalancati come fanali e tutti i muscoli del corpo tesi come corde di violino: quel formicolio era piacevole; mi piaceva sempre di più man mano che aumentava. Mi sentivo eccitata quasi come se stessi per raggiungere un orgasmo…
No, non era possibile… non in quelle condizioni; piena da scoppiare, con un paletto d’acciaio piantato nel culo che emetteva un perpetuo pizzicore; davanti a dieci persone che osservavano ogni mio buco, ogni millimetro quadrato del mio corpo … stavo per godere: non era possibile!
Invece sì. Me ne stavo venendo. Stavo per avere un orgasmo di quelli favolosi; da ricordare nella vita.
Ancora oggi, al solo ricordo, mi sento crescere l’eccitazione dentro.
Serrai gli occhi avvertendo l’aumento del formicolio della corrente elettrica; era insopportabile eppure piacevolissimo. Afferrai i braccioli della poltrona e tirai allo spasimo sollevando, per quanto possibile, la testa, il busto, le anche e gridai, gridai, gridai dentro me stessa, stringendo tra i denti la palla di gomma che mi impediva di urlare al mondo il mio godimento.
Improvvisamente il formicolio cessò ma fu come se il mio corpo non se ne fosse accorto: ero come in preda alle convulsioni. Gli orgasmi continuavano a susseguirsi ad un ritmo impressionante: non avevo mai provato niente del genere; mi calmavo per qualche istante per ricominciare immediatamente dopo a tremare e scuotermi in preda ad un’altra serie di orgasmi. In poco più due minuti ne ebbi almeno una trentina. Pian piano mi calmai ma, a brevi intervalli di tempo, i muscoli della vagina e dell’ano ricominciavano a tremare irrigidendosi senza che il mio cervello impartisse alcun ordine.
Dio, non potevo credere a quello che mi era successo.
Ero sfinita; svuotata di ogni energia, spalmata sulla poltrona.
Aprì gli occhi e mi vidi riflessa nello specchio: stentai a riconoscermi. I capezzoli, nonostante il dolore delle pinze, erano grossi e dritti come pollici. La pancia ed il pube mi tremavano come se fossero fatti di gelatina.
Con orrore mi accorsi che gli spettatori erano tutti in piedi; si erano avvicinati e mi fissavano, da brevissima distanza, eccitati dai miei orgasmi, dalle mie reazioni convulse. Poi mi resi conto che non me ne fregava niente: loro non sapevano cosa avessi provato; quale piacere mi avesse regalato la loro punizione; fui quasi tentata di ringraziarli mentalmente finché il formicolio delle scosse non riprese.
Nella mia testa, tutto divenne improvvisamente rosa; i muscoli s’irrigidirono nuovamente lottando contro i legacci; e ripresero anche gli orgasmi; lenti, non più rapidi come prima, ma potenti, forse più potenti.
Ero sfinita; non avevo più saliva nella bocca. Le braccia, le gambe, le spalle, il collo erano tutto un dolore.
Durò a lungo, questa volta; almeno un quarto d’ora, ma non fu piacevole come la volta precedente: gli orgasmi, quando arrivarono, erano diventati dolorosi, insopportabili. La testa mi pulsava come se ci stesse lavorando dentro un martello pneumatico. Le mammelle mi erano diventate di fuoco; l’ano mi bruciava da impazzire; volevo andarmene, volevo scendere da quella maledetta poltrona, togliermi di dentro tutti quei tubi, volevo pisciare, volevo cagare. Mi accorsi che stavo piangendo come una disperata: ero disperata.
Le scariche elettriche si fermarono; lentamente riuscì a rilassarmi. Non sapevo cosa mi facesse più male: ero tutta un unico, grande dolore.
Il formicolio riprese, leggero ma costante: ancora diverso dalle volte precedenti. Aumentava e diminuiva; aumentava e diminuiva portandomi sull’orlo dell’orgasmo per lasciarmi lì, insoddisfatta sia nel piacere che nel dolore.
Lentamente arrivarono gli orgasmi: piacevoli; dolorosi; forti; appena percettibili; non lo so; non lo ricordo più.
Non ricordo quante volte la corrente cessò di percorrere il mio corpo; quante volte mi dettero il tempo di riprendermi per ricominciare a punirmi subito dopo.
Credo di essere svenuta, perché i miei ricordi si perdono per riprendere con il medico che mi stava auscultando il cuore con lo stetoscopio.
- Tutto bene; è una donna molto forte, e, devo ammettere, con un corpo ed una sessualità veramente eccezionali. – le sue mani mi accarezzarono le tette soffermandosi sui capezzoli straziati dalle pinze, poi scesero in basso spingendomi sulla pancia – l’intestino è duro, ma ancora regge molto bene – poi mi premette sul pube facendomi mugugnare dal dolore – È ora di prosciugarle la vescica: anche se ha sudato molto, i suoi reni hanno prodotto sicuramente una gran quantità di liquidi, che aggiunti al mezzo litro che le abbiamo istillato noi, devono averla portata al limite della resistenza. -
Sentì che trafficava tra le mie cosce ed immediatamente dopo avvertì una sensazione di benessere celestiale: la mia vescica si stava svuotando.
Non m’importava niente di farmi vedere da tutta quella gente mentre pisciavo: era una sensazione meravigliosa che mi ripagava abbondantemente dell’umiliazione che stavo subendo.
Brividi di piacere percorrevano tutto il mio corpo mentre si allentava la pressione nella mia vescica; mi sembrò durasse un’eternità: sicuramente quella fu la più lunga pisciata della mia vita; non finiva mai.
Purtroppo, invece, terminò; l’infermiera tolse la bacinella nella quale era fluita tutta la mia urina e la punizione ricominciò.
Come aveva annunciato all’inizio, il medico collegò nuovamente la cannula che stava saldamente infilata nel mio canale ureterale alla sacca più piccola che pendeva sopra di me ed incominciò a riempirmi nuovamente. Avvertì nettamente il freddo della soluzione sterile allagarmi la vescica finché non mi sembrò, di nuovo, di aver bisogno urgente di urinare; ma questa volta non mi fu permesso. Dovevo tenermela per altre due interminabili ore.
Subito dopo il formicolio della corrente ricominciò a farsi sentire in tutto il mio corpo e ricominciarono gli orgasmi: piacevoli, devastanti, crudeli, dolcissimi.
Passai per tutte le gamme e le sfaccettature del piacere e del dolore: volevo che quella punizione finisse all’istante o aspettavo con ansia l’esplosione del prossimo orgasmo; maledicevo il mio corpo per essere così sensibile o mi crogiolavo nel piacere dei piccoli, ripetuti, ravvicinati orgasmi. Di una cosa però ero certa: non sarei sopravvissuta a quella punizione.
Dopo che la mia vescica fu svuotata e riempita per la quarta volta, ero talmente sfinita, distrutta, priva di ogni minima forza che ebbi la certezza che al primo nuovo potente orgasmo sarei morta.
Non fu così. Seppi di aver superato le prime dieci ore di punizione quando mi accorsi che il medico stava togliendo le pinze che mi avevano martoriato i capezzoli.
Il dolore fu terribile.
Evidentemente tutti sapevano quali sarebbero state le mie reazioni, infatti, mi accorsi, con sgomento, che erano tutti e dieci nuovamente intorno a me, a pascersi dell’ultimo dolore che mi stavano procurando. Ultimo dolore, ma non ultima umiliazione. Quella arrivò proprio alla fine quando, dopo aver tolto le sonde dal canale urinario e dal collo dell’utero, il medico si accinse a togliermi il paletto dal culo. Avevo sperato che mi sciogliessero permettendomi di andare in bagno, da sola; non fu così. L’infermiera depose un secchio sotto il sedile della poltrona un attimo prima che il medico sfilasse la grossa cannula.
Sentì avvamparmi dalla vergogna, ma provai anche lo stesso enorme, indicibile piacere che avevo provato ogni volta che mi avevano svuotato la vescica.
I due infermieri mi sciolsero e mi sorressero mentre mi facevano indossare nuovamente il camice. Sorreggendomi, mi condussero ancora nella stanza del medico capo, dove il dottore mi sottopose a nuovi controlli. Massaggiarono le mie parti intime ed i miei capezzoli martoriati con creme ed unguenti lenitivi.
Impiegai più di un’ora per riprendere un accettabile controllo di me stessa e delle mie forze.
Mentre mi aiutava a rivestirmi, chiesi all’infermiera che ora fosse: le sei e quarantacinque di sabato mattina. Ero entrata in quello studio quasi dodici ore prima ed ora stavo per uscirne dopo aver subito la più sconvolgente esperienza della mia vita.
Il Medico Capo, aprì gentilmente la porta dello studio per farmi uscire.
- Un taxi l’aspetta all’ingresso – mi disse – non è il caso che guidi nelle sue condizioni. Vada a casa e si faccia un lungo sonno ristoratore. Noi ci rivedremo venerdì prossimo alle diciassette. Mi raccomando: sia puntuale se non vuole che le raddoppino la pena.
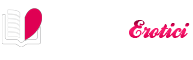











AAzart
Giovanna
AAzart
Evoman
Post New Comment